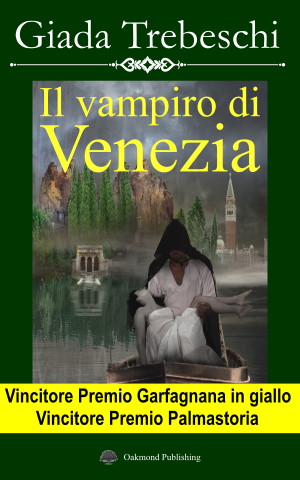I
Quando infine gli tagliarono la giugulare, non ci mise molto a morire. Fece appena in tempo a sentire il fiotto caldo del proprio sangue scivolargli lungo il collo prima del sopraggiungere di quello stato d’incoscienza simile al sonno, alla pace, alla morte tanto agognata. Durante il lungo supplizio al quale era stato sottoposto, seppe di essere dannato. Una vita intera a predicare la parola di Dio e ora la perdizione. Se non fosse stato per quegli occhi, neri come l’oscurità del peccato, che lo fissavano così da vicino, non avrebbe neppure saputo perché. Il terrore della punizione eterna gli si era insinuato nella mente come il brulichio di migliaia di vermi. Li aveva sentiti muoversi, masticargli le membra, avvertendo l’odore della propria carne in putrefazione e dei liquami che non era riuscito a trattenere che gli si seccavano addosso.
Era stato appeso per i piedi. Un oggetto freddo gli aveva sfiorato le parti intime. Certamente un coltello, ma in quegli ultimi momenti di delirio si era lasciato andare al ricordo di esperte dita sottili, forse giovani labbra o forse la lingua, sì, la lingua appuntita di una cortigiana. Aveva avuto un’erezione ma non era stato il culmine del piacere a provare per quella che sapeva sarebbe stata la sua ultima volta. Il dolore aveva raggiunto un picco insopportabile, e solo il terrore che gli si era incuneato fra il cervello e l’anima non gli aveva permesso di svenire. Pensò che lo avrebbero mangiato vivo.
Furono i due ragazzini che andavano a prepararsi per servire messa a trovarlo. Erano entrati in chiesa dalla porta principale dato che, stranamente, avevano trovato chiusa quella della sagrestia. Il più grande dei due aveva avuto conati di vomito, l’altro non era più riuscito a parlare per mesi. Lo spettacolo che avevano visto era raccapricciante. Non sarebbero mai più entrati nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, neppure da adulti.
Sul corpo nudo di Don Alvise la luce delle candele creava ombre che lo facevano sembrare un essere demoniaco. O meglio, un dannato cui erano state inflitte pene infernali e che ora si presentava al mondo con gli occhi girati al contrario, il volto bloccato in una smorfia di dolore e paura insieme, la carne in molti punti a brandelli e la lingua strappata e gettata come una bestemmia sull’altare maggiore. Sembrava esser stato dilaniato da una bestia feroce ma non vi erano quasi tracce di sangue.
«Tiratelo giù. E mandate fuori tutti» ordinò Orso Maria Pisani, il signore di notte al Criminàl, ovvero il magistrato cui erano stati affidati i compiti di controllo e gendarmeria in quel sestiere, quello di Dorsoduro.
Si sarebbe occupato lui di quel caso.
Era la vigilia di Natale del 1576 e, seppur con la paura della peste, la chiesa si andava riempiendo di curiosi richiamati dalle grida disperate dei ragazzi e dal trambusto che ne era seguito.
Davanti al morto, ancora penzolante dall’arco centrale dell’iconostasi bizantina, proprio a specchio rovesciato sotto il Cristo crocifisso, in molti si erano segnati. Bisbigliavano, ipnotizzati dal macabro spettacolo, dicendosi che quella poteva essere solo opera del diavolo. Così come lo era la terribile pestilenza che affliggeva la città e che sembrava non voler lasciar scampo a nessuno.
Gli untori erano di sicuro stati mandati dal signore delle tenebre, e doveva esserlo anche chi aveva osato compiere un’azione come quella, in una chiesa e, per colmo di blasfemia, la vigilia di Natale. Era un segno, un messaggio ultraterreno di chi voleva capovolgere l’ordine delle cose, così come aveva capovolto e martoriato il povero Don Alvise.
Tutte quelle chiacchiere, confuse tra scoppi di pianto isterico e preghiere più urlate che sussurrate, stavano dando sui nervi a Orso Maria Pisani. Patrizio veneziano dalla mente scientifica e razionale, che guardava con disprezzo tutto ciò che derivava dalla superstizione e dall’ignoranza, era certo che ogni spiegazione avesse le proprie radici in questo mondo e non in quell’altro, della cui esistenza, a ben vedere, non era nemmeno tanto sicuro. Ma erano convincimenti, questi, che riteneva prudente tenere per sé. Dovevano restare riflessioni private, così da preservare la libertà di pensare ciò che voleva. Venezia era una città di mercanti e traffichini che accettava di fare affari con gli infedeli, che ospitava ebrei, seppur nel ghetto, che riusciva, il più delle volte, a tener lontana l’Inquisizione e la lunga mano del Papa, ma non era il caso di provare fino a che punto fosse disposta ad accettare provocazioni su questioni di fede.
L’ultimo bagliore del crepuscolo si era già spento da un pezzo quando, finalmente, il corpo di Don Alvise venne adagiato su un lenzuolo ai piedi dell’altare.
«Portate altre candele» ordinò Pisani.
«Sembra essere stato aggredito a morsi. Non ho mai visto una cosa del genere. La ferocia di chi si è accanito sul suo corpo farebbe impallidire un branco di lupi» commentò sbigottito il cavadenti che era arrivato in chiesa per la messa ed era stato poi trattenuto per esaminare il corpo di Don Alvise.
«Lupi che oltre a sbranarlo vivo devono anche aver leccato via tutto il sangue» commentò Pisani quasi parlando a se stesso. «Una tale efferatezza e nemmeno una goccia di sangue sul pavimento.»
Era l’unico dettaglio che lo lasciasse davvero sgomento. Un dettaglio che fece persino vacillare la sua granitica razionalità: che ci fosse veramente lo zampino del demonio? Scacciò quel pensiero come si allontana una mosca fastidiosa, e cercò di raccogliere le idee.
Il modo in cui il povero prete era stato issato a penzolare dall’iconostasi era piuttosto interessante. Per ridurre lo sforzo di tirare la corda era stato utilizzato un sistema di cime e bozzelli del tutto simili a quelli dei paranchi delle navi, lasciando supporre che l’assassino, che a maggior ragione doveva essere un uomo e non un essere dai poteri soprannaturali, avrebbe potuto lavorare all’Arsenale o essere un marinaio. Inoltre, il nodo fatto alla fune legata attorno a una colonna per sorreggere il corpo sembrava proprio una gassa d’amante. La cosa poteva certo orientare le indagini verso l’ambiente marinaresco ma, in fondo, a Venezia ogni uomo sopra e forse anche sotto i quattordici anni avrebbe potuto far quel nodo o conoscere quel sistema. No, quella pista non lo avrebbe condotto da nessuna parte.
Il corpo di Don Alvise fu portato sul tavolo della sagrestia. Bisognava ispezionarlo minuziosamente prima di concedere il permesso alla tumulazione. E, giacché il prete non era morto di peste, si poteva attendere qualche ora in più prima seppellirlo.
Così fu mandato a chiamare, scortato fino al luogo del delitto, uno dei più noti cerusici ebrei della città. Pisani sperava che avrebbe potuto dare una spiegazione ai segni di morsi sulle povere membra del prete.
«A parte la lingua recisa di netto, il resto della carne sembra essere stato strappato a morsi. Di queste ferite ne ho contate sei. Sei, come il salmo che dice: Signore non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore» fu l’asciutto commento del cerusico.
«Quando è morto?»
«Da qualche ora, direi.»
«E il sangue, dov’è finito?» chiese nervoso Pisani, che si aspettava molto di più.